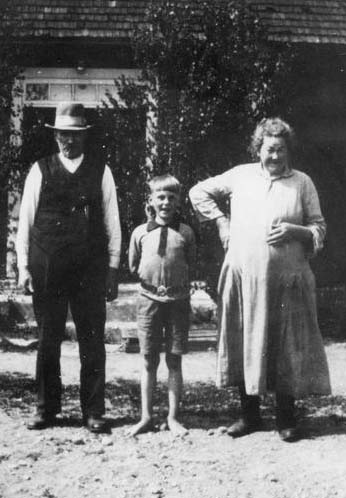di Massimo Chiucchiù
Maneggiare un autore particolare come Fernando Pessoa mi crea forte imbarazzo e sincera apprensione, non tanto per la scarsa conoscenza, avendo presente nella mia biblioteca solo il leggendario “Libro dell’inquietudine“, quanto per gli abissi mentali a cui questo scrittore, considerato con Borges uno dei massimi poeti del XX secolo, ti conduce con alacre perizia.Cosa si deve pensare di un artista che passa tutta la sua vita,fin dall’età di sette anni, alla creazione
di pseudonimi, ed in seguito di eteronimi ?( gli eteronimi sono personalità poetiche complete: identità che, inizialmente inventate, divengono autentiche attraverso la loro personale attività artistica, diversa e distinta da quella dell’autore originale).Nella lettera ad Adolfo Casais Monteiro del 13 gennaio 1935, interrogato da questo sulla genesi dei suoi eteronimi, scrive:
“L’origine dei miei eteronimi è il tratto profondo di isteria che esiste in me. […] L’origine mentale dei miei eteronimi sta nella mia tendenza organica e costante alla spersonalizzazione e alla simulazione. Questi fenomeni, fortunatamente, per me e per gli altri, in me si sono mentalizzati; voglio dire che non si manifestano nella mia vita pratica, esteriore e di
contatto con gli altri; esplodono verso l’interno e io li vivo da solo con me stesso.»

Un profondo disturbo mentale che diventa arte e pensiero vertiginoso;ci sarebbe tanto da scrivere su cosa sia la pazzia o la normalita’,ma andrei come si dice fuori tema.Tengo per me l’inquietudine ammirata scaturente dal percorrere i sentieri mentali del poeta portoghese per soffermarmi su un libro da lui scritto e a me colpevolmente sconosciuto fino ad oggi,
che viene a proposito per contribuire ad approfondire il ruolo della libertà nella teoria anarchica.
Conoscendo parzialmente gli interessi e gli scritti di Pessoa,riguardanti poemi,poesie,opere disperse e pubblicate dopo la sua morte,per la gioia di esegeti ed editori alla scoperta dei suoi giacimenti letterari, viste dall’occhio di un autore che si definisce conservatore di stile inglese, cioè liberale all’interno del conservatorismo e assolutamente antireazionario,
rimango stupito scoprendo che ebbe anche a scrivere un libricino il cui titolo mi appare assolutamente attraente, cioè “Il banchiere anarchico“, da cui sono stati tratti piéce teatrali ed un recente film del regista Giulio Base.
Da subito il titolo del libro appare un ossimoro,una contraddizione in termini,un ircocervo di dubbia utilità, però ha l’enorme pregio di mettere in dubbio ,con solide argomentazioni razionali, l’impossibilità della messa in pratica della teoria libertaria. Lascio al lettore il giudizio sull’opera di Pessoa, di gradevole lettura,che pone questioni riguardanti teorie e pratiche politiche nel domestico alveo della personale interrogazione psicologica e di scelta di vita,come solo un simile autore sa fare, per soffermarmi infine sulle confutazioni e riletture del pensiero anarchico rischiarato da un punto di vista così severo come quello
del grande portoghese, o chi per lui se trattasi di uno dei suoi innumerevoli eteronimi.
IL BANCHIERE ANARCHICO
Avevamo appena finito di cenare. Di fronte a me il mio amico, il banchiere, grande
commerciante e notevole monopolista, fumava come uno che non ha pensieri. La conversazione, che si era andata spegnendo a poco a poco, giaceva morta fra di noi. Tentai di rianimarla, a caso, servendomi di una idea che mi balenò in mente mentre riflettevo. Mi rivolsi a lui e gli sorrisi. «Pensi: tempo fa mi hanno detto che lei, in passato, è stato anarchico».
«Non che lo sia stato: lo sono stato e lo sono. Non sono cambiato in questo. Sono anarchico».
«Questa è buona! Lei anarchico! In che cosa è anarchico?… Solo se dà alla parola un significato
diverso… »
«Da quello comune? No, proprio no. Uso la parola nel senso comune».
«Intende dire, dunque, di essere anarchico esattamente nello stesso senso in cui sono anarchici quei tizi delle organizzazioni operaie? Allora fra lei e quei tizi delle bombe e dei sindacati non c’è nessuna differenza?»
«Di differenze, di differenze ce ne sono… È chiaro che c’è differenza. Ma non quella che pensa
lei. Crede forse che le mie teorie sociali siano uguali alle loro?»
«Ah, ho capito! Lei, in teoria, è anarchico; in pratica…»
«In pratica sono tanto anarchico quanto lo sono in teoria. E in pratica lo sono di più, molto di
più di quegli individui che lei ha citato. Tutta la mia vita lo dimostra».
«Come?!»
«Tutta la mia vita lo dimostra, ragazzo mio. Lei non è mai stato ben attento a queste cose.
Perciò le pare che io stia dicendo una scemenza, o che la stia prendendo in giro».
«Diavolo, non ci capisco niente!… A meno che… a meno che lei non giudichi la sua vita
destabilizzante e antisociale e dia all’anarchia questo significato».
«Le ho già detto di no — cioè, le ho già detto che non do alla parola “anarchia” un significato
diverso da quello comune».
«Va bene… Continuo a non capire… Senta, vuole dirmi che non c’è differenza fra le sue teorie
veramente anarchiche e la pratica della sua vita — la pratica della sua vita come è adesso? Vuole che creda che lei ha una vita uguale in tutto e per tutto a quella degli individui che di solito si definiscono anarchici? »
«No; non è questo. Quello che voglio dire è che fra le mie teorie e la pratica della mia vita non
esiste alcuna divergenza, ma anzi un’assoluta conformità. Che io non abbia una vita come quella dei tizi dei sindacati e delle bombe, questo è vero. Ma è la loro vita a non essere in linea con l’anarchia, con i loro ideali. La mia no. In me — sì, in me, banchiere, grande commerciante, monopolista se vuole—, in me la teoria e la pratica dell’anarchia sono unite e ambedue provate. Lei mi ha paragonato a quegli sciocchi dei sindacati e delle bombe per indicare che sono diverso da loro. Lo sono, ma la differenza è questa: loro (sì, loro, e non io) sono anarchici solo in teoria; io, invece, lo sono nella teoria e nella pratica. Loro sono anarchici e stupidi, io anarchico e intelligente. Cioè, vecchio mio, sono io il vero anarchico. Loro — quelli dei sindacati e delle bombe (ci sono stato in mezzo anch’io e ne sono uscito proprio per la mia vera anarchia) — loro sono la spazzatura, le meretrici della grande dottrina libertaria».
«Questa poi! Ma come! Come concilia la sua vita — voglio dire la sua vita bancaria e
commerciale — con le sue teorie anarchiche? Come la concilia, se dice che per teorie anarchiche intende esattamente quello che gli anarchici comuni intendono? E lei, per di più, sostiene di essere diverso da loro perché più anarchico di loro — è vero o no?»
«Certo».
«Non ci capisco niente».
«Ma lei ha voglia di capire?»
«Tutta la voglia».
Tolse dalla bocca il sigaro, che si era spento, lo riaccese lentamente; fissò il fiammifero che si
consumava; lo depose con delicatezza nel portacenere. Poi, rialzando il capo che per un momento aveva chinato, disse:
«Ascolti. Sono figlio del popolo e della classe operaia della città. Di buono non ho ereditato,
come può immaginare, né la condizione, né le circostanze. Mi è solo capitato di avere un’intelligenza lucida e una volontà abbastanza forte. Ma questi erano doni naturali, che la mia bassa nascita non mi poteva strappare.
Ho fatto l’operaio, ho lavorato, ho vissuto una vita difficile: sono stato, in breve, quello che la
maggior parte della gente è in quell’ambiente. Non dico di aver patito la fame, ma ci sono andato vicino. Avrei potuto patirla, del resto, e questo non avrebbe cambiato nulla di quello che è accaduto dopo, o di quello che le sto per raccontare; né di quello che è stata la mia vita, né di quello che è adesso.

Sono stato un comune operaio, insomma; come tutti, lavoravo perché dovevo lavorare, e
lavoravo il meno possibile. L’unica cosa è che ero intelligente. Appena potevo leggevo, discutevo e, siccome non ero stupido, sono sorti in me una grande insoddisfazione e un grande senso di ribellione contro il mio destino e contro le condizioni sociali che lo rendevano tale. Le ho già detto, in tutta sincerità, che esso avrebbe potuto essere peggiore di quello che era; ma a quel tempo mi sentivo un essere contro cui la sorte aveva commesso ogni tipo d’ingiustizia, servendosi delle convenzioni sociali per mandarle ad effetto. Questo accadeva quando avevo una ventina d’anni — ventuno, al massimo — e fu allora che divenni anarchico».
Tacque per un momento. Si voltò un po’ di più verso di me. Poi riprese a parlare, inclinandosi
ancora un poco.
«Sono sempre stato più o meno lucido. Mi sono sentito indignato. Ho voluto capire la mia
indignazione. Sono diventato anarchico conscio e convinto — l’anarchico conscio e convinto che sono oggi».
«E la sua teoria di adesso, è la stessa di allora?»
«Proprio la stessa. La teoria anarchica, la vera teoria, è una sola. La mia è quella che ho sempre
sostenuto, fin da quando sono diventato anarchico. Vedrà… Stavo dicendo che, dato che ero lucido per natura, sono diventato un anarchico cosciente. Ora, che cos’è un anarchico? È una persona indignata nei confronti dell’ingiustizia di essere nati, noi, socialmente diversi — in fondo è solo questo. E da questo deriva, come si vedrà, la rivolta contro le convenzioni sociali che rendono possibile questa disuguaglianza. Quello che le sto mostrando adesso è il percorso psicologico, cioè come si diventa anarchici. E passiamo alla parte teorica della questione. Per ora, cerchi di capire quale sarebbe la rivolta di un individuo intelligente che venga a trovarsi nelle mie condizioni di allora. Cosa vede nel mondo?
Uno nasce figlio di un milionario, protetto fin dalla culla contro quegli incidenti — e non sono pochi — che il denaro può evitare o limitare; un altro nasce miserabile; ossia, quando è bambino, è una bocca in più in una famiglia in cui di bocche ce n’è d’avanzo rispetto a quanto c’è da mangiare. Uno nasce conte o marchese, e per questo gode della considerazione di tutti: faccia pure quel che gli pare. Un altro nasce come me, e deve stare ben attento se vuole che lo trattino, almeno, come un essere umano. Qualcuno nasce in condizioni tali da poter studiare, viaggiare, istruirsi — diventare, si può dire, più intelligente degli altri che per natura lo sono di più. E così via, in tutto…
Le ingiustizie della natura, va bene: non le possiamo evitare. Ora, quelle della società e delle
sue convenzioni, queste, perché non evitarle? Accetto — non posso farci niente — che un uomo sia superiore a me per quello che la natura gli ha dato — il talento, la forza, l’energia; non accetto che sia superiore a me per qualche qualità posticcia, con la quale non è uscito dal ventre di sua madre, ma che gli è capitata per caso non appena è comparso al mondo: la ricchezza, la posizione sociale, la vita facile eccetera. Fu dalla rivolta che le sto illustrando con queste considerazioni che nacque la mia anarchia di allora — anarchia che, gliel’ho già detto, continuo a serbare in me senza differenza, inalterata».
Si fermò di nuovo un momento, come per pensare a cosa dire poi. Fumò e soffiò il fumo
lentamente, verso il lato opposto a quello dove mi trovavo io. Si voltò, e stava per proseguire. Io, però, lo interruppi.
«Una domanda, per curiosità… Come mai è diventato proprio anarchico? Avrebbe potuto
diventare socialista, o sposare qualsiasi altra idea progressista che non fosse così sovversiva, ma che fosse comunque in linea con la sua rivolta… Deduco da quanto ha detto che per anarchia lei intende (e penso che vada bene come definizione dell’anarchia) la ribellione contro tutte le convenzioni e le formule sociali, il desiderio e lo sforzo per l’abolizione di tutte…»
«Esattamente».
«Perché ha scelto questa formula estremista e non si è deciso per una delle altre… di quelle
intermedie? »
«Glielo spiego. Ho pensato a lungo a tutto ciò. È chiaro che nei volantini che leggevo potevo
vedere tutte queste teorie. Ho scelto la teoria anarchica — estremista, come lei la definisce molto bene — per alcune ragioni che le esporrò in due parole».
Guardò per un attimo nel nulla. Poi si rivolse a me.
«Il vero male, l’unico male, sono le convenzioni e le finzioni sociali, che si sovrappongono alla
realtà naturale: tutto, dalla famiglia al denaro, dalla religione allo stato. La gente nasce uomo o donna— voglio dire, nasce per essere nell’età adulta uomo o donna; non nasce, in un giusto stato di natura, né per essere marito, né per essere ricco o povero, come non nasce nemmeno per essere cattolico o protestante, portoghese o inglese. Tutte queste distinzioni vengono fatte in virtù delle finzioni sociali.
Ora, queste finzioni sociali sono inique, ma perché? Perché sono finzioni, perché non sono naturali.
Tanto iniquo è il denaro quanto lo stato, tanto l’organizzazione della famiglia quanto le religioni. Se ne esistessero altre, oltre a queste, sarebbero ugualmente inique, perché anch’esse sarebbero finzioni, perché anche esse si sovrapporrebbero e ostacolerebbero la realtà naturale. Ora, qualsiasi sistema che non sia il puro sistema anarchico, che vuole l’abolizione di tutte le finzioni e di ognuna di esse completamente, è anch’ esso una finzione. Impiegare tutta la nostra volontà, tutto il nostro sforzo, tutta la nostra intelligenza per instaurare, o per contribuire a instaurare una finzione sociale invece di un’altra è un assurdo, se non addirittura un delitto, perché vuol dire creare un sommovimento sociale con il fine dichiarato di lasciare tutto com’è. Se troviamo ingiuste le finzioni sociali, perché schiacciano e opprimono quanto c’è di naturale nell’ uomo, perché impiegare il nostro sforzo a sostituire queste finzioni con altre, se possiamo impiegarlo per distruggerle tutte?
Questo mi sembra conclusivo. Ma supponiamo che non lo sia; supponiamo che ci obiettino che,per quanto giusto, il sistema anarchico non è realizzabile in pratica. Esaminiamo un po’ questo aspetto del problema.
Per quale motivo il sistema anarchico non sarebbe realizzabile? Tutti noi progressisti partiamo
dal principio che non solo l’attuale sistema è ingiusto, ma che è vantaggioso, perché ci sia giustizia, sostituirlo con un altro più giusto. Se non la pensiamo così, non siamo progressisti, ma borghesi. Ora, da dove viene questo criterio di giustizia? Da ciò che è naturale e vero, in opposizione alle finzioni sociali e alla falsità delle convenzioni. Ora, è naturale ciò che è interamente naturale, non ciò che è naturale a metà, o per un quarto, o per un ottavo. Molto bene. Ora, di due cose una: o ciò che è naturale è realizzabile socialmente o non lo è; in altre parole, o la società può essere naturale, o la società è essenzialmente finzione e non può essere naturale in alcun modo. Se la società può essere naturale, può esistere la società anarchica, o libera; e deve esistere, perché è quella la società interamente naturale. Se la società non può essere naturale, se (per qualche motivo che non importa) deve per forza essere finzione, allora il minore dei mali: facciamola, all’ interno di questa finzione inevitabile, nel modo più naturale possibile, affinché sia proprio per questo la più giusta possibile. Qual è la finzione più naturale? Nessuna è naturale in sé, perché è finzione; la più naturale, nel nostro caso, sarà quella che sembra più naturale, che noi sentiamo come più naturale. Qual è quella che sembra più naturale, o che sentiamo come più naturale? È quella alla quale siamo abituati. (Lei capisce: ciò che è naturale è ciò che viene dall’istinto; e quello che, non essendo istinto, assomiglia in tutto e per tutto all’istinto è l’abitudine. Fumare non è naturale, non è una necessità dell’ istinto, ma, se ci abituiamo a fumare, diventa per noi naturale, comincia a essere sentito come una necessità dell’istinto). Ora, qual è la finzione sociale che costituisce una nostra abitudine? È il sistema attuale, il sistema borghese. Ne deriva dunque, a rigor di logica, che o troviamo possibile la società naturale, e saremo difensori dell’anarchia; o non la giudichiamo possibile, e saremo difensori del regime borghese. Non esistono ipotesi intermedie. Capisce? »
«Sissignore: questo è conclusivo».
«No; c’è ancora un’altra obiezione dello stesso tipo da liquidare. Si può concordare che il
sistema anarchico sia realizzabile, ma si può dubitare che sia realizzabile all’improvviso — cioè che si possa passare dalla società borghese alla società libera senza che ci siano uno o più stadi o regimi intermedi. Chi fa questa obiezione accetta come buona, o come realizzabile, la società anarchica; ma immagina che debba esserci uno stadio qualsiasi di transizione fra la società borghese e quella nuova.
Benissimo. Supponiamo che sia così. Cos’è questo stadio intermedio? Il nostro fine è la società
anarchica, o libera; questo stadio intermedio può essere solo, quindi, uno stadio di preparazione dell’ umanità alla società libera. Questa preparazione o è materiale, o è semplicemente mentale; cioè, o è una serie di realizzazioni materiali e sociali che adattano un po’ alla volta l’umanità alla società libera, o è una semplice propaganda che cresce e influisce gradualmente, che la prepara mentalmente a desiderarla e ad accettarla.
Esaminiamo il primo caso, l’adattamento graduale e materiale dell’umanità alla società libera. È
impossibile; è più che impossibile: è assurdo. Non esiste adattamento materiale se non a una cosa che già esiste. Nessuno di noi può adattarsi materialmente al livello sociale del secolo XXIII, anche nel caso sappia quale sarà; e non ci si può adattare materialmente perché il secolo XXIII e il suo livello sociale non esistono ancora materialmente. Così arriviamo alla conclusione che, nel passaggio dalla società borghese alla società libera, l’unico possibile adattamento (evoluzione o transizione) è mentale:
cioè il graduale adattamento degli spiriti all’idea della società libera. In tutti i casi, nel campo
dell’adattamento materiale, c’è ancora un’ipotesi…»
«Basta con tante ipotesi!»
«Ragazzo mio, l’uomo lucido deve esaminare tutte le obiezioni possibili e confutarle, prima di
potersi dire certo della sua dottrina. E, per di più, tutto ciò è in risposta a una domanda che mi ha fatto lei».
«Va bene».
«Nel campo dell’adattamento materiale, dicevo, c’è in ogni caso un’altra ipotesi; quella della
dittatura rivoluzionaria».
«Dittatura rivoluzionaria in che senso?»
«Come le ho spiegato, non può esserci adattamento materiale a una cosa che non esiste ancora materialmente. Ma se, con un brusco sommovimento, si fa la rivoluzione sociale, viene introdotta non la società libera (perché a questa l’umanità non può ancora essere preparata), ma una dittatura da parte di coloro che vogliono instaurare la società libera. Esiste già però, anche se a uno stadio embrionale, esiste già materialmente qualcosa della società libera. C’è già dunque una realtà materiale, alla quale l’umanità possa adattarsi. È questo l’argomento con cui gli imbecilli che sostengono la “dittatura del proletariato” la difenderebbero se fossero capaci di ragionare o di pensare. Il discorso, è chiaro, non è loro: è mio. Lo faccio come obiezione a me stesso. E, come le mostrerò… è falso.
Un regime rivoluzionario, in quanto esiste, e qualunque sia il fine cui tende o l’idea che lo
guida, è materialmente solo una cosa: un regime rivoluzionario. Ora, un regime rivoluzionario significa una dittatura di guerra, o, in sostanza, un regime dispotico, perché lo stato di guerra è imposto alla società da una sua parte — quella che ha preso il potere con la rivoluzione. Cosa ne risulta? Ne risulta che chi si adatta a questo regime, come all’unica cosa che è materialmente e immediatamente, si adatta a un regime militare dispotico. L’idea che ha condotto i rivoluzionari, la meta verso la quale tendevano, è completamente sparita dalla realtà sociale, che è occupata esclusivamente dal fenomeno bellico.
Così, ciò che deriva da una dittatura rivoluzionaria — e in modo tanto più evidente quanto più questa dittatura durerà — è una società guerriera di tipo dittatoriale, cioè un dispotismo militare. Nient’altro.
Ed è sempre stato così. Io non conosco molto la storia, ma quello che so concorda con questo; e non potrebbe essere altrimenti. Cosa è venuto fuori dalle agitazioni politiche di Roma? L’impero romano e il suo dispotismo militare. Cosa è venuto fuori dalla rivoluzione francese? Napoleone e il suo dispotismo militare. E vedrà cosa verrà fuori dalla rivoluzione russa… Qualcosa che ritarderà di decine di anni la realizzazione della società libera. Ma cosa dovevamo aspettarci da un popolo di analfabeti e di mistici?
Be’, questo è già fuori tema… Ha capito il mio ragionamento?»
«Perfettamente».
«Lei capisce quindi che sono arrivato a questa conclusione:
fine: la società anarchica e libera,
mezzo: il passaggio, senza transizione, dalla società borghese alla società libera.Questo passaggio sarebbe preparato e reso possibile da una propaganda intensa, completa, avvincente, tale da predisporre tutti gli spiriti e indebolire tutte le resistenze. È chiaro che per “propaganda” non intendo solo la parola scritta e parlata: intendo tutto, l’azione indiretta o diretta, qualsiasi cosa possa predisporre alla società libera e indebolire la resistenza al momento del suo avvento. Così, essendo assai scarsa la resistenza da vincere, la rivoluzione sociale, quando venisse, sarebbe rapida, facile, e non dovrebbe instaurare alcuna
dittatura rivoluzionaria, non essendoci nessuno contro cui istituirla. Se questo non può essere, vuol dire che l’anarchia è irrealizzabile; e se l’anarchia è irrealizzabile, è difendibile e giusta solo la società borghese, come già le ho provato.
Ora, lei mi ha chiesto perché e come sono diventato anarchico, perché e in che modo ho
respinto come false e contro natura le altre dottrine sociali di minor audacia.
E va bene… continuiamo la mia storia».
Sfregò un fiammifero e accese lentamente il suo sigaro. Si concentrò, e dopo un attimo
proseguì:
«C’erano molti altri ragazzi con le mie stesse opinioni. La maggior parte di essi erano operai,
ma c’era anche chi non lo era; eravamo tutti poveri e, per quanto mi è dato ricordare, non molto stupidi.
Avevamo una certa volontà di istruirci, di apprendere, e nello stesso tempo il desiderio di propagandare e diffondere le nostre idee. Volevamo per noi e per gli altri — per l’umanità intera — una società nuova, libera da tutti quei preconcetti che rendono gli uomini disuguali artificialmente e impongono loro inferiorità, sofferenze, ristrettezze che la natura non ha imposto loro. Quanto a me, ciò che leggevo mi confermava queste opinioni. In libri libertari di poco prezzo — quelli che si trovavano all’epoca, ed erano già sufficienti — ho letto quasi tutto. Sono stato a conferenze e comizi dei propagandisti di quel tempo. Ogni libro e ogni discorso mi convincevano sempre più della sicurezza e dell’equità delle mie idee. Quello che pensavo allora — glielo ripeto, amico mio — è quello che penso oggi; l’unica differenza è che allora lo pensavo solamente, mentre oggi lo penso e lo metto in pratica».
«Va bene, fin qui sono d’accordo. È fuor di dubbio che lei sia diventato anarchico così, e vedo
perfettamente che lei era anarchico. Non ho bisogno di altre prove. Quel che voglio sapere è come da questo sia venuto fuori il banchiere, come ne sia venuto fuori senza contraddizioni. Cioè, più o meno, sto già calcolando…»
«No, non calcoli niente. So cosa vuol dire. Lei si basa sui miei discorsi, che ha appena finito di
sentire, e pensa che io abbia trovato l’anarchia irrealizzabile e quindi, come le ho detto, difendibile e giusta solo la società borghese, vero?»
«Sì, ho pensato che fosse più o meno così».
«Ma come poteva essere, se fin dall’inizio del discorso le ho detto e ripetuto di essere
anarchico, che non solo lo sono stato ma che continuo a esserlo? Se fossi diventato banchiere e
commerciante per la ragione che lei pensa, non sarei anarchico, ma borghese».
«Sì, ha ragione. Ma allora come diavolo…? Su, su, mi dica…»
«Come le ho detto, ero (lo sono sempre stato) abbastanza lucido, ed ero anche un uomo
d’azione. Queste sono qualità naturali: non me le hanno messe nella culla (se mai ne ho avuta una), sono io ad averle sviluppate. Bene. Essendo anarchico, trovavo insopportabile essere anarchico solo in modo passivo, solo per ascoltare discorsi e parlarne con gli amici. No: bisognava fare qualcosa! Bisognava lavorare e lottare per la causa degli oppressi e delle vittime delle convenzioni sociali! Decisi di darmi da fare, per quanto fosse in mio potere. Mi misi a pensare a come avrei potuto essere utile alla causa libertaria. Cominciai a tracciare il mio piano d’azione.
Che cosa vuole l’anarchico? La libertà: la libertà per sé e per gli altri, per tutta l’umanità. Vuole
essere libero dall’influenza o dalla pressione delle finzioni sociali; vuole essere libero come quando è nato ed è comparso nel mondo, come deve essere secondo giustizia; e vuole questa libertà per sé e per tutti gli altri. Non tutti possono essere uguali di fronte alla natura: chi nasce alto, chi basso; chi forte, chi debole; uno più intelligente, l’altro meno… Ma da questo punto in avanti tutti possono essere uguali: solo le finzioni sociali fanno sì che ciò non avvenga. E proprio queste finzioni bisognava distruggere.
Bisognava distruggerle, dunque, ma non mi è sfuggito un aspetto importante: bisognava
distruggerle a vantaggio della libertà, e tenendo sempre ben in vista la creazione della società libera. Perché il fatto di distruggere le finzioni sociali può servire sia a creare libertà, o a preparare la via alla libertà, sia a stabilire altre finzioni sociali diverse, ugualmente inique perché ugualmente finzioni. Era qui che bisognava fare attenzione. Si doveva trovare un modo d’azione, qualunque fosse la sua violenza o la sua nonviolenza (perché contro le ingiustizie sociali tutto era legittimo), con cui si potesse contribuire a distruggere le finzioni sociali senza, al tempo stesso, ostacolare la creazione della libertà futura; gettando anzi, nel caso fosse possibile, le sue basi.
È chiaro che questa libertà, che bisognava stare attenti a non ostacolare, è la libertà futura e, nel presente, la libertà degli oppressi dalle finzioni sociali. Va da sé che non dobbiamo salvaguardare la “libertà” dei potenti, dei ben piazzati, di tutti quelli che rappresentano le finzioni sociali e ne traggono vantaggio. Questa non è libertà; è libertà di tiranneggiare, l’esatto contrario della libertà. Noi dobbiamo ostacolarla e combatterla col massimo impegno. Mi sembra che questo sia chiaro».
«Chiarissimo. Continui…»
«Per chi l’anarchico vuole la libertà? Per l’umanità intera. Qual è il sistema per conseguire la
libertà per l’umanità intera? Distruggere totalmente tutte le finzioni sociali. In che modo distruggere totalmente tutte le finzioni sociali? Le ho già anticipato la spiegazione quando, per rispondere alla sua domanda, ho discusso gli altri sistemi progressisti e le ho spiegato come e perché ero anarchico.
Ricorda la mia conclusione?»
«Sì, certo».
«Una rivoluzione sociale improvvisa, brusca, radicale, che facesse passare la società,
all’improvviso, dal regime borghese alla società libera. Una rivoluzione sociale preparata da un lavoro intenso e continuo, di azione diretta e indiretta, tendente a disporre tutti gli spiriti verso l’avvento della società libera, e a indebolire fino allo stato comatoso tutte le resistenze della borghesia… Mi scusi se le ripeto le ragioni che portano inevitabilmente a questa conclusione, in linea con il pensiero anarchico; gliele ho già esposte e lei le ha già capite».
«Sì».
«Questa rivoluzione, di preferenza, dovrebbe avvenire su scala mondiale, in tutti i paesi
simultaneamente, o nei punti strategici del mondo; oppure, in caso contrario, propagandosi con rapidità da uno stato all’altro; ma comunque in ogni punto, cioè in ogni nazione, fulminea e completa.
Bene. Cosa potevo fare io a questo scopo? Da solo non avrei potuto farla, la rivoluzione
mondiale, e nemmeno avrei potuto fare la rivoluzione totale nel paese in cui mi trovavo. Potevo solo lavorare, col massimo sforzo, per preparare questa rivoluzione. Le ho già spiegato come: combattendo le finzioni sociali con tutti i mezzi possibili; senza ostacolare la lotta, ma sostenendola, e facendo propaganda alla società libera, alla libertà futura, alla libertà presente degli oppressi; creando già, qualora fosse possibile, le basi della futura libertà».
Tirò un po’ di fumo; fece una breve pausa; poi ricominciò.
«A questo punto, amico mio, la mia lucidità è entrata in azione. Lavorare per il futuro, va bene,
pensavo; lavorare perché gli altri siano liberi, va bene. Ma io? Io non ero nessuno? Se fossi stato
cristiano, avrei lavorato serenamente per il futuro degli altri, perché avrei avuto la mia ricompensa in cielo; ma se fossi stato cristiano non sarei stato anarchico, perché in questo caso le disuguaglianze non avrebbero avuto importanza nella nostra breve vita: avrebbero rappresentato i normali limiti della precaria condizione umana, e sarebbero state ricompensate con la vita eterna. Ma io non ero cristiano, così come non lo sono ora, e mi chiedevo: ma per chi devo sacrificarmi in questo modo? E poi, ancora:
perché devo sacrificarmi?
Ho avuto momenti di sfiducia; e lei capisce che erano giustificati. Sono materialista, pensavo;
non ho altra vita che questa; per quale motivo devo affliggermi con propagande, disuguaglianze sociali e altri problemi, quando potrei godere e distrarmi molto di più se non mi preoccupassi di tutto ciò? Chi ha solo questa vita, chi non crede nella vita eterna, chi non ammette leggi al di fuori di quelle della natura, chi si oppone allo stato perché non è naturale, al matrimonio perché non è naturale, al denaro perché non è naturale, a tutte le finzioni sociali perché non sono naturali, per quale ragione predica l’altruismo e il sacrificio per gli altri, o per l’umanità, se l’altruismo e anche il sacrificio non sono naturali? Sì, la stessa logica che mi dimostra che un uomo non nasce per essere sposato, o per essere portoghese, o per essere ricco o povero, mi dimostra anche che egli non nasce se non per essere se stesso; niente affatto altruista e solidale, quindi, ma esclusivamente egoista.
Ho discusso la questione tra me e me. Guarda, dicevo a me stesso, che apparteniamo per nascita alla specie umana, e che abbiamo il dovere di essere solidali con tutti gli uomini. Ma l’idea di “dovere” era naturale? Da dove veniva? Se essa mi obbligava a sacrificare il mio benessere, la mia comodità, il mio istinto di conservazione e gli altri miei istinti naturali, in che cosa divergeva l’azione di questa idea dall’azione di qualsiasi finzione sociale, che produce in noi esattamente lo stesso effetto?
Quest’idea di dovere, di solidarietà umana, avrebbe potuto essere considerata naturale solo se
avesse portato con sé una compensazione dal punto di vista dell’egoismo, perché allora, sebbene contraria di principio all’egoismo naturale, avrebbe fornito a tale egoismo una ricompensa, ristabilendo in questo modo l’equilibrio. Sacrificare un piacere, il solo fatto di sacrificarlo, non è naturale; sacrificare un piacere per un altro, be’, questo è secondo natura: significa, fra due cose naturali, se non si possono avere entrambe, sceglierne una; il che va benissimo. Ora, quale ricompensa egoistica, o naturale, poteva darmi la dedizione alla causa della società libera e della futura felicità umana? Solo la coscienza del dovere compiuto, dello sforzo per un buon fine; e nessuna di queste cose è una ricompensa egoistica, nessuna un piacere in sé, ma un piacere, se tale, nato da una finzione, come può essere il piacere di essere immensamente ricco, o il piacere di essere nato in una buona posizione sociale.

Le confesso, vecchio mio, che ho avuto momenti di sfiducia. Mi sono sentito sleale nei
confronti della mia dottrina, come un traditore. Ma in poco tempo ho superato ogni dubbio. L’idea di giustizia è qui, dentro di me, ho pensato. Sentivo che essa era naturale. Sentivo che esisteva un dovere superiore alla semplice preoccupazione per il mio destino. E sono andato avanti nel proposito».
«Non mi sembra che questa decisione riveli una grande lucidità da parte sua. Lei non ha risolto
la difficoltà, lei è andato avanti seguendo un impulso del tutto sentimentale».
«Senza dubbio. Ma quello che le sto raccontando adesso è la storia di come sono diventato
anarchico, e di come ho continuato e continuo a esserlo. Le sto esponendo lealmente le esitazioni e le difficoltà che ho avuto, e come le ho vinte. Concordo sul fatto che, in quel momento, vincevo la difficoltà logica con il sentimento, e non con la ragione. Ma vedrà che successivamente, quando sono arrivato alla totale comprensione della dottrina anarchica, questa difficoltà, rimasta fino ad allora senza una risposta logica, ha avuto la sua soluzione completa e assoluta».
«È curioso».
«Sì. Adesso mi lasci continuare la mia storia. Avevo questa difficoltà, e cercavo di risolverla,
anche se male, come le ho detto. Subito dopo, fra i tanti pensieri, è sorta un’altra difficoltà; e anch’essa mi ha lasciato abbastanza confuso.
Mi stava bene, diciamo, di sacrificarmi senza alcuna ricompensa propriamente personale, voglio dire, veramente naturale. Ma supponiamo che la società futura non desse nulla di quanto speravo, che fosse impossibile costruire una società libera, per quale diavolo di motivo io, in questo caso, mi stavo sacrificando? Sacrificarmi per un’idea senza ricompense personali, senza guadagnare nulla col mio sforzo per questa idea, andava bene; ma sacrificarmi senza nemmeno avere la certezza che quello per cui lavoravo sarebbe esistito un giorno, senza che l’idea stessa vincesse grazie al mio sforzo, questo era un po’ troppo. Fin da ora le dico che ho risolto la difficoltà con lo stesso procedimento sentimentale
con cui ho risolto l’altra; ma l’avverto anche che, come è avvenuto per l’altra, l’ho risolta poi con la logica, automaticamente, quando sono arrivato allo stadio pienamente cosciente della mia anarchia. Poi vedrà… All’epoca di cui le sto raccontando, mi sono tirato d’impiccio con una o due frasi accomodanti.
“Io faccio il mio dovere verso il futuro, che il futuro faccia il suo dovere verso di me”. Questo pensavo, o qualcosa di simile.
Ho esposto questa conclusione, anzi, queste conclusioni, ai miei compagni; tutti loro hanno
convenuto con me sul fatto che bisognava andare avanti e fare tutto per la società libera. È vero che qualcuno, fra i più intelligenti, è rimasto un po’ turbato da quanto ho detto, non perché non condividesse la mia prospettiva, ma perché non aveva mai visto le cose così chiaramente, né le difficoltà che la situazione comportava. Ma alla fine sono stati tutti d’accordo: saremmo tutti andati a lavorare per la grande rivoluzione sociale, per la società libera, che il futuro ci giustificasse o no!
Abbiamo formato un gruppo, fra gente fidata, e abbiamo incominciato una grande propaganda — grande, è chiaro, nei limiti delle nostre possibilità. Durante un buon lasso di tempo, in mezzo a difficoltà, complicazioni e a volte persecuzioni, abbiamo lavorato per l’ideale anarchico».
Il banchiere, arrivato a questo punto, fece una pausa un po’ più lunga. Non accese il sigaro, che
si era di nuovo spento. Poi, all’improvviso, abbozzò un sorriso e, con l’aria di chi sta per arrivare al punto cruciale, mi guardò con maggior insistenza e proseguì, schiarendosi la voce e accentuando maggiormente le parole.
«A questo punto — disse lui — si è presentato un nuovo problema. “A questo punto” è un
modo di dire. Voglio dire che, dopo qualche mese di questa propaganda, ho iniziato a valutare una nuova complicazione; e questa era la più seria di tutte, era seria per davvero…
Si ricorda, no?, del fatto in base al quale io, mediante un ragionamento rigoroso, avevo stabilito
quale dovesse essere il modo di procedere degli anarchici. Un modo o dei modi qualsiasi attraverso i quali si contribuisse a distruggere le finzioni sociali senza, al tempo stesso, ostacolare la creazione della libertà futura; senza quindi limitare minimamente la già poca libertà degli attuali oppressi dalle finzioni sociali; un modo di procedere che possibilmente gettasse le basi della libertà futura.
Bene: una volta stabilito questo criterio, non ho mai smesso di tenerlo presente. Ora, al
momento della propaganda di cui le sto parlando, ho scoperto una cosa. Nel gruppo di propaganda — non eravamo molti, una quarantina di persone, se non sbaglio — accadeva questo: si produceva tirannia».
«Si produceva tirannia? E come?»
«Nel modo seguente: qualcuno comandava sugli altri e ci portava dove voleva; qualcun altro si
imponeva e ci obbligava a essere quello che più piaceva a lui; altri ancora trascinavano i compagni dove volevano, con imbrogli e artifici vari. Non dico che si comportassero così in situazioni gravi: non c’erano situazioni gravi nell’attività che svolgevamo. Ma il fatto è che questo avveniva sempre e invariabilmente, e non solo durante il lavoro di propaganda, ma anche al di fuori, nelle normali circostanze della vita. Qualcuno andava impercettibilmente verso le posizioni di comando, altri impercettibilmente verso il ruolo di subordinati. Qualcuno era capo per imposizione, qualcun altro per imbroglio. Ciò era evidente nei casi più banali. Per esempio: due ragazzi camminavano insieme per una qualsiasi strada; vi arrivavano in fondo: uno doveva andare a destra e l’altro a sinistra; ognuno di loro aveva convenienza ad andare dalla sua parte. Ma quello che andava a sinistra diceva all’altro: “Vieni con me, da questa parte”; l’altro rispondeva, ed era vero, “Senti, non posso: devo andare di là” per questa o quella ragione. Alla fine, contro la sua volontà e la sua convenienza, seguiva l’altro prendendo a sinistra.
Questo si verificava una volta per persuasione, un’altra per semplice insistenza, una terza volta
per un qualsiasi altro motivo… Voglio dire, non era mai per una ragione logica; c’era sempre in questa imposizione e in questa subordinazione un che di spontaneo, di istintivo. E come in questo semplice caso, così in tutti gli altri, da quelli di minore a quelli di maggior importanza… Ha capito il problema? »
«Sì. Ma cosa diavolo c’è di strano in questo? È quanto di più naturale si possa immaginare!»
«Sarà. Ci arriveremo fra poco. Quello che le chiedo di notare è che si trattava dell’esatto
contrario della dottrina anarchica. E badi che questo si verificava in un piccolo gruppo, senza
influenza né importanza, cui non era affidata la soluzione di alcun problema grave o la decisione su alcun argomento importante; in un gruppo di persone che si erano unite soprattutto per fare quanto era in loro potere per la causa dell’anarchia — cioè per combattere, nei limiti del possibile, le finzioni sociali, e per creare, nei limiti del possibile, la futura libertà. Ha capito bene questi due punti?»
«Sì».
«Consideri bene ciò che questo rappresenta: un piccolo gruppo di gente sincera (le garantisco
che era sincera!), consolidato e unito espressamente per lavorare alla causa della libertà, aveva
ottenuto, dopo qualche mese, una sola cosa positiva e concreta: la creazione, al suo interno, della tirannia. E guardi un po’ che tirannia: non era la tirannia derivata dall’ azione delle finzioni sociali che, seppur deprecabile, sarebbe stata comprensibile, fino a un certo punto; ma meno in noi, che combattevamo tali finzioni, che non in altri (alla fin fine, vivevamo in una società basata su queste finzioni, e non era solo colpa nostra se non riuscivamo a sfuggire del tutto al loro raggio d’azione). Ma non era questo il problema. Coloro che comandavano sugli altri, o che li portavano dove volevano, non lo facevano per la brama del denaro, o della posizione sociale, o di qualsiasi autorità di natura fittizia che potessero arrogarsi; lo facevano per una ragione qualsiasi al di fuori delle finzioni della società.
Questa tirannia, cioè, relativamente a tali finzioni, era una tirannia nuova. Ed era esercitata nei
confronti di gente già oppressa dalle finzioni sociali. Era, per di più, una tirannia esercitata fra di loro da parte di persone la cui intenzione sincera era quella di distruggere la tirannia e di creare la libertà.
Adesso poniamo lo stesso caso in un gruppo molto più ampio, molto più influente, che affronti
già questioni importanti e decisioni di portata fondamentale. Immagini questo gruppo intento, come il nostro, a indirizzare i suoi sforzi verso la formazione di una società libera. Mi dica allora se attraverso questo carico di tirannie incrociate lei intravvede la possibilità di una società libera o di un’umanità degna di questo nome».
«Già, tutto questo è molto curioso».
«È curioso, vero? E badi che ci sono alcuni aspetti secondari, anch’essi molto curiosi. Per
esempio: la tirannia dell’aiuto».
«La che cosa?»
«La tirannia dell’aiuto. Fra di noi c’erano alcuni che invece di comandare sugli altri, invece di
imporsi agli altri, li aiutavano anzi con tutte le loro forze. Sembra il contrario, non è vero? Ma guardi bene di cosa si trattava, in realtà. Era proprio la nuova tirannia. Era proprio come andare contro i principi anarchici».
«Questa è buona! E perché?»
«Aiutare qualcuno, amico mio, vuol dire prendere qualcuno per incapace; se questo qualcuno
non è incapace, significa farlo tale, supporlo tale; e cioè, nel primo caso, tirannia, nel secondo
disprezzo. In un caso si distrugge la libertà altrui; nell’altro si parte, perlomeno inconsciamente, dal principio che gli altri sono spregevoli e indegni o incapaci di libertà.
Torniamo al nostro caso. Lei vede bene che questo fatto era gravissimo. Che lavorassimo per la
società futura senza aspettarci che essa ci ringraziasse, o rischiando addirittura che tale società non arrivasse mai, tutto questo andava bene. Ma era davvero troppo che stessimo a lavorare per un futuro di libertà e che non facessimo altro, di positivo, che creare tirannia, ma una tirannia nuova, esercitata da noi, gli oppressi, gli uni sugli altri. Ora, questo non poteva essere.
Mi sono messo a riflettere. Doveva esserci un errore, una deviazione qualsiasi. Le nostre
intuizioni erano buone; le nostre dottrine sembravano sicure; erano forse sbagliati i nostri modi d’agire?
Certo, che lo erano. Ma dove diavolo stava l’errore? Ho iniziato a pensare; stavo diventando matto. Un giorno, improvvisamente, come sempre succede in queste cose, ho trovato la soluzione. È stato il gran giorno delle mie teorie anarchiche; il giorno in cui ho scoperto, per così dire, la tecnica dell’anarchia».
Mi guardò per un attimo senza vedermi. Poi continuò, sullo stesso tono di voce.
«Ho pensato questo: abbiamo una tirannia nuova, una tirannia che non è derivata dalle finzioni
della società. Da dove, allora, è derivata? Dalle qualità naturali? Se è così, addio società libera! Se una società in cui agiscono solo le qualità naturali degli uomini — quelle qualità con cui essi nascono, che essi devono solo alla natura e sulle quali non abbiamo alcun potere —, se una società in cui agiscono solo queste qualità è un cumulo di soprusi, chi alzerà il mignolo per contribuire all’ avvento di questa società? Tirannia per tirannia, che resti quella che c’è; almeno è quella cui siamo abituati, e per questo, fatalmente, la sentiamo meno di quanto sentiremmo una tirannia nuova, terribile come tutte le cose tiranniche che vengono direttamente dalla natura. Contro di essa non ci sarebbe rivolta possibile, così come non esiste rivolta possibile contro il fatto di dover morire, o contro l’esser bassi quando si preferirebbe essere nati alti. Proprio per questo le ho già provato che, se per qualsiasi ragione non è realizzabile la società anarchica, deve esistere allora, in quanto più naturale di qualsiasi altra eccetto quella, la società borghese.
Ma questa tirannia, che nasceva così dentro di noi, era realmente derivata dalle qualità naturali?
Ora, cosa sono le qualità naturali? Sono il grado di intelligenza, di immaginazione, di volontà, eccetera, con cui ognuno nasce — questo nel campo mentale, è chiaro, perché le qualità naturali del corpo non sono casuali. Ora, un individuo che comanda un altro per una ragione diversa da quelle derivate dalle finzioni della società, lo fa necessariamente perché gli è superiore in qualcuna delle qualità naturali. Lo domina con l’uso di tali qualità. Ma c’è una cosa da verificare: questo impiego delle qualità naturali sarà legittimo? Cioè, sarà naturale?
Ora, qual è il naturale impiego delle nostre qualità naturali? Servire ai fini naturali della nostra
personalità. Ma dominare qualcuno è un fine naturale della nostra personalità? Può esserlo; esiste un caso in cui può esserlo: quando questo qualcuno si trova a ricoprire, rispetto a noi, il ruolo di nemico.
Per l’anarchico, è chiaro, tale ruolo è occupato da qualsiasi rappresentante delle finzioni della società e della sua tirannia; da nessun altro, perché tutti gli altri uomini sono uomini come lui e compagni naturali. Ora, vede, il caso della tirannia che stavamo creando fra di noi non era questo; la tirannia che stavamo creando era esercitata su uomini come noi, compagni naturali, doppiamente compagni, addirittura, perché lo erano anche per la comunione nello stesso ideale. Conclusione: questa nostra tirannia, se non era derivata dalle finzioni della società, non era derivata neanche dalle qualità naturali; era derivata da un’applicazione errata, da una perversione delle qualità naturali. E questa perversione, da dove proveniva?
Le risposte potevano essere due: o l’uomo è naturalmente cattivo, e quindi tutte le qualità
naturali sono naturalmente perverse; o la perversione deriva dalla lunga permanenza dell’umanità in un’atmosfera di finzioni sociali, tutte quante generatrici di tirannia e tendenti quindi a rendere già istintivamente tirannico l’uso più naturale delle qualità più naturali. Ora, di queste due ipotesi, qual era quella giusta? Era impossibile determinarlo in modo soddisfacente, cioè rigorosamente logico o scientifico. Il ragionamento non ha niente a che vedere con questo problema, che è di ordine storico, o scientifico, e dipende dalla conoscenza di fatti. Da parte sua, nemmeno la scienza ci aiuta, perché, per quanto torniamo indietro nella storia, troviamo l’uomo sempre sottomesso all’uno o all’altro sistema di tirannia sociale, e quindi sempre in uno stato che non ci permette di verificare come sia l’uomo quando vive in condizioni genuine e interamente naturali. Non essendoci una risposta certa, dobbiamo propendere per la soluzione più probabile; e la maggior probabilità è nella seconda ipotesi. È più naturale supporre che la lunghissima permanenza dell’umanità tra finzioni sociali generatrici di tirannia faccia sì che ogni uomo (anche chi non abbia l’intenzione cosciente di tiranneggiare) nasca con qualità naturali già deviate verso una tirannia spontanea, che non supporre che delle qualità naturali possano essere naturalmente pervertite, cosa che di certo rappresenta una contraddizione. Per questo motivo, chi ci pensa si decide per la seconda ipotesi, come ho fatto io.
Dunque, una cosa è evidente: nel presente stato sociale non è possibile che un gruppo di uomini, per quanto benintenzionati, per quanto intenti a combattere le finzioni della società e a conquistare la libertà, lavorino uniti senza creare spontaneamente fra di loro una tirannia, senza creare fra di loro una tirannia nuova, supplementare a quella delle finzioni sociali, senza distruggere nella pratica quanto vogliono in teoria, senza involontariamente ostacolare al massimo lo stesso progetto che vogliono promuovere. Cosa si deve fare? È molto semplice: lavorare tutti per lo stesso fine, ma separati».
«Separati?»
«Sì, non ha seguito il mio discorso?»
«Sì, certo».
«E non trova logica, non trova fatale questa conclusione? »
«Sì che la trovo… Quello che non capisco bene è come questo…»
«Adesso glielo spiego. Ho detto: lavoriamo tutti per lo stesso fine, ma separati. Lavorando tutti
per lo stesso fine anarchico, ognuno contribuisce con il suo sforzo alla distruzione delle finzioni della società (questo è il nostro obiettivo) e alla creazione della società libera del futuro; e lavorando separati nessuno può in alcun modo creare una nuova tirannia, perché nessuno ha la possibilità di agire sull’ altro, e non può quindi né, dominandolo, usurpare la sua libertà né, aiutandolo, limitarla.
Lavorando così separati e per lo stesso fine anarchico abbiamo due vantaggi: quello dello sforzo congiunto e quello della non creazione di una nuova tirannia. Proseguiamo uniti perché lo siamo moralmente e lavoriamo allo stesso modo per lo stesso fine; continuiamo a essere anarchici, perché ognuno lavora per la società libera; ma la smettiamo di essere traditori, volontari o involontari, nei confronti della nostra causa; cessiamo anche di poterlo essere, perché ci collochiamo, grazie al lavoro anarchico isolato, fuori dell’influenza deleteria delle finzioni sociali, del loro riflesso ereditario sulle qualità che la natura ci ha dato.
È chiaro che tutta questa tattica si applica a quello che io ho chiamato il periodo di
preparazione della rivoluzione sociale. Una volta cadute le difese borghesi, e ridotta tutta la società allo stato di accettazione delle dottrine anarchiche, mancando solo la rivoluzione sociale vera e propria, allora, per il colpo finale, non può continuare l’azione separata. Ma a questo punto la società libera è già virtualmente esistente; le cose vanno già in un altro modo. La tattica cui faccio allusione si riferisce solo all’azione anarchica nel seno della società borghese, come nel caso del gruppo al quale io appartenevo.
Era questo — finalmente! — il vero processo anarchico. Insieme non valevamo niente, e per
più ci tiranneggiavamo e ci ostacolavamo gli uni con gli altri, intralciando lo sviluppo delle nostre teorie. Separati, avremmo ottenuto ugualmente poco, ma almeno non avremmo ostacolato la libertà, non avremmo creato una nuova tirannia; quel che avessimo raggiunto, per poco che fosse, sarebbe stato effettivamente raggiunto, senza perdite né svantaggi. E sempre più, lavorando così separati, avremmo imparato ad aver fiducia in noi stessi, a non appoggiarci gli uni agli altri, a renderci già più liberi, a prepararci, sia personalmente che nei confronti degli altri mediante il nostro esempio, per il futuro.
Ero raggiante di fronte a questa scoperta. Sono andato subito a esporla ai miei compagni. È stata una delle poche volte in cui mi sono sentito stupido nel corso della mia vita. Si immagini che ero tanto preso dalla mia scoperta da aspettarmi che loro fossero d’accordo!»
«E invece no, è chiaro…»
«Hanno protestato, amico mio, hanno protestato tutti! Chi più chi meno, ma tutti hanno
protestato! Non era così! Non era possibile! Ma nessuno diceva quel che era o quel che doveva essere.
Ho parlato e parlato, e in risposta alle mie argomentazioni non ho ottenuto altro che frasi, spazzatura, banalità come quelle che i ministri dicono alle camere quando non hanno alcuna risposta… È stato allora che ho capito con che imbecilli e con che codardi mi ero messo! Si erano smascherati. Quella combriccola era nata per essere schiava. Volevano essere anarchici sulle spalle degli altri. Volevano la libertà, a patto che fossero gli altri a conquistargliela, a patto che fosse data loro così come da un re viene conferita un’onorificenza. Quasi tutti loro sono così, quei grandi lacchè!»
«E lei si è arrabbiato?»
«Se mi sono arrabbiato! Mi sono infuriato! Mi sono messo a scalciare. Ho fatto fuoco e fiamme.
Sono quasi venuto alle mani con due o tre di loro. E ho finito per andarmene. Mi sono isolato. Mi è venuta una tale nausea nei confronti di tutto quel branco di pecoroni, che non se l’immagina nemmeno!
Ho quasi rinnegato l’anarchia. Ho quasi deciso di non interessarmi più di tutta la faccenda. Ma, dopo qualche giorno, sono tornato in me. Ho pensato che l’ideale anarchico era al di sopra di simili piccolezze. Loro non volevano essere anarchici? Lo sarei stato io. Loro volevano solo giocare a fare i libertari? Non ero disponibile per un simile gioco. Loro non avevano la forza di combattere se non appoggiandosi gli uni agli altri e creando fra di loro un nuovo simulacro della tirannia che sostenevano di voler combattere? E allora che lo facessero, quegli idioti, se non servivano ad altro. Io non sarei diventato borghese per così poco.
Era stabilito che, nella vera anarchia, ognuno dovesse con le proprie forze creare libertà e
combattere le finzioni sociali. E allora, con le mie forze, avrei creato libertà e combattuto queste finzioni. Nessuno voleva seguire con me il vero cammino dell’anarchia? Lo avrei seguito io. Lo avrei fatto: da solo, con le mie risorse, con la mia fede, isolato persino dall’ appoggio mentale di quelli che erano stati i miei compagni, contro tutte le finzioni sociali. Non dico che fosse un bel gesto, né un gesto eroico. È stato solo un gesto naturale. Se la via doveva essere seguita da ognuno separatamente, non avevo bisogno di nessun altro per seguirla. Bastava il mio ideale. È stato basandomi su questi principi e su queste circostanze che ho deciso, io solo, di combattere le finzioni della società».
Interruppe un attimo il suo discorso, che si era fatto caloroso e fluente. Lo riprese poco dopo,
con la voce già più pacata.
«È uno stato di guerra, ho pensato, fra me e le finzioni sociali. Molto bene. Che posso fare io
contro tali finzioni? Lavoro da solo per non creare, in nessun modo, alcuna forma di tirannia. Come posso lavorare da solo alla preparazione della rivoluzione sociale, alla preparazione dell’umanità in vista della società libera? Devo scegliere uno dei due procedimenti possibili; nel caso, è chiaro, che non possa servirmi di entrambi. I due procedimenti sono l’azione indiretta, cioè la propaganda, e l’azione diretta, di qualsiasi tipo.
Ho pensato in primo luogo all’azione indiretta, cioè alla propaganda. Che propaganda avrei
potuto fare io, da solo? A parte quella propaganda che si fa sempre quando si chiacchiera, con l’uno o con l’altro, a casaccio e servendosi di tutti gli spunti, ciò che volevo sapere era se l’azione indiretta era una via su cui potessi incamminare la mia attività di anarchico in modo energico; in modo, cioè, da produrre risultati di qualche rilievo. Ho constatato subito che non poteva essere così. Non sono né un oratore né uno scrittore. Voglio dire: sono capace di parlare in pubblico, se necessario, e sono capace di scrivere un articolo per un giornale; ma quello che volevo verificare era se la mia conformazione naturale indicava che, specializzandomi nell’azione indiretta, di uno solo o di entrambi i tipi, avrei potuto ottenere risultati più positivi per l’idea anarchica che non indirizzando i miei sforzi in qualsiasi altro senso. Ora, l’azione è sempre più fruttuosa della propaganda; tranne nel caso di quegli individui la cui indole li destina essenzialmente al ruolo di propagandisti — i grandi oratori, capaci di elettrizzare e di trascinare le masse, o i grandi scrittori, capaci di affascinare e di convincere con i loro libri. Non mi sembra di essere molto vanitoso ma, se lo sono, la mia vanità non mi permette, perlomeno, di insuperbirmi per qualità che non posseggo. E, come le ho detto, non è mai successo nulla che mi permettesse di considerarmi un oratore o uno scrittore. Per questo ho abbandonato l’idea dell’azione indiretta come via da seguire nella mia attività di anarchico. Per esclusione ero costretto a scegliere l’azione diretta, cioè lo sforzo applicato alla pratica della vita, alla vita reale. Non era l’intelligenza, ma l’azione. Molto bene. Così sarebbe stato.
Dovevo quindi applicare alla vita pratica il procedimento fondamentale dell’azione anarchica,
che avevo già chiarito: combattere le finzioni della società senza creare una nuova tirannia, e creando già, nel caso fosse possibile, le basi della libertà futura. Ma come diavolo si fa tutto questo, nella pratica?
Ora, cosa significa combattere nella pratica? Combattere nella pratica significa la guerra, una
guerra, perlomeno. Come si fa la guerra alle finzioni sociali? Prima di tutto, come si fa la guerra? Come è che si vince il nemico, in qualsiasi guerra? In uno dei due modi: o uccidendolo, cioè distruggendolo, o imprigionandolo, cioè soggiogandolo, riducendolo all’ inazione. Di distruggere le finzioni sociali non ero in grado; solo la rivoluzione sociale poteva farlo. Le finzioni della società potevano essere attaccate, traballanti, a un filo; ma distrutte lo sarebbero state solo con la venuta della società libera e la reale caduta della società borghese. Il massimo che avrei potuto fare in questo senso era distruggere — distruggere nel senso fisico di uccidere — qualche membro delle classi rappresentative della società borghese. Ho studiato la cosa, e mi sono accorto che era una sciocchezza. Provi a immaginarmi intento ad ammazzare uno, due, una dozzina di rappresentanti della tirannia delle finzioni sociali. Con che risultato? Forse che tali finzioni si sarebbero indebolite? No. Le finzioni della società non sono come una situazione politica, che può dipendere da un ristretto numero di uomini, a volte da un uomo solo.
Quello che c’è di ingiusto nelle finzioni sociali sono le finzioni stesse, nel loro insieme, e non gli
individui che le rappresentano se non, appunto, in quanto loro rappresentanti. E poi, un attentato di ordine sociale provoca sempre una reazione; non solo tutto resta come prima, ma il più delle volte peggiora. Supponga per di più che, come è naturale, dopo un attentato io fossi ricercato; ricercato e liquidato in un modo o nell’altro. E supponga anche che io avessi eliminato una dozzina di capitalisti.
Che cosa avrebbe prodotto tutto questo, in definitiva? Con la mia liquidazione, magari non per morte, ma per semplice prigione o esilio, la causa anarchica avrebbe perso un elemento di lotta: e i dodici capitalisti soppressi non sarebbero stati dodici elementi che la società borghese perdeva, perché i componenti di tale società non sono elementi di lotta, bensì elementi puramente passivi, dato che la “lotta” anarchica deve rivolgersi non contro i membri della società borghese, ma contro l’insieme di finzioni sociali in cui questa società si colloca stabilmente. Ora, le finzioni sociali non sono persone, contro le quali si possa sparare… Capisce? Non era come il soldato di un esercito che uccide dodici soldati dell’esercito nemico; era come un soldato che uccide dodici civili della nazione dell’altro esercito. Voleva dire uccidere senza ragione, perché non si eliminava nessun combattente. Non potevo, quindi, pensare di distruggere, né in toto né in minima parte, le finzioni sociali. Dovevo sconfiggerle soggiogandole, riducendole all’ inazione». Puntò verso di me, all’ improvviso, l’indice della mano destra.
«È quello che ho fatto!»
Si ricompose, e continuò.
«Ho cercato di considerare quale fosse la prima, la più importante delle finzioni sociali. Questa,
prima di qualunque altra, dovevo tentare di soggiogare, di ridurre all’inazione. La più importante, perlomeno nella nostra epoca, è il denaro. Come soggiogare il denaro, o, più precisamente, la forza e la tirannia del denaro? Liberandomi dalla sua influenza, dalla sua forza, rendendomi superiore, quindi, alla sua influenza, neutralizzando la sua azione su di me. Su di me, capisce? Perché ero io a combattere: se si fosse trattato di ridurlo all’inazione rispetto a tutti, non sarebbe stato più soggiogarlo, bensì distruggerlo, perché avrebbe significato farla finita del tutto con la finzione denaro. Ora, le ho già provato che qualsiasi finzione sociale può essere “distrutta” solo dalla rivoluzione sociale, trascinata con le altre nella caduta della società borghese.
Come potevo rendermi superiore alla forza del denaro dalla sfera della sua influenza, cioè dalla civiltà; andare in un campo a mangiare radici e? Il modo più semplice era allontanarmi a bere acqua dalle fonti; girare nudo e vivere come un animale. Ma questo, e non avrei avuto nessuna difficoltà a farlo, non significava combattere una finzione sociale; non era nemmeno combattere: era fuggire. Dal punto di vista dei fatti, chi si sottrae a una lotta non è sconfitto nella lotta stessa. Ma moralmente lo è, perché non si è battuto. Il metodo doveva essere un altro — un metodo di lotta e non di fuga. Come soggiogare il denaro, combattendolo? Come sottrarmi alla sua influenza e alla sua tirannia, senza evitare lo scontro con esso? Il procedimento era uno solo: guadagnarlo, guadagnarlo in quantità sufficiente da non sentirne il bisogno; e quanto più ne avessi guadagnato, tanto più sarei stato libero da tale bisogno. È stato quando ho visto questo in modo chiaro, con tutta la forza della mia convinzione di anarchico e con tutta la mia logica di uomo lucido, che sono entrato nella fase attuale — quella commerciale e bancaria, amico mio — della mia anarchia».
Calmò, per un attimo, l’ardore e l’entusiasmo per quanto stava dicendo. Poi, sempre con un
certo fervore, continuò il suo racconto.
«Ora, si ricorda di quelle due difficoltà logiche che erano sorte, come le ho raccontato, all’inizio
della mia carriera di anarchico cosciente? E si ricorda che le ho detto di averle risolte a quell’epoca artificialmente, con il sentimento e non su base logica? Lei stesso ha notato, e molto bene, che non le avevo risolte logicamente».
«Certo, ricordo…»
«E si ricorda di quando le ho detto che più tardi, quando finalmente ho capito la natura del vero processo anarchico, le ho risolte una buona volta a rigor di logica?»
«Sì».
«Ora consideri come sono state risolte. Le difficoltà erano queste: non è naturale lavorare per
una causa, quale che sia, senza una ricompensa naturale, cioè egoistica; e non è naturale che noi diamo il nostro contributo per un fine qualsiasi senza avere la soddisfazione di sapere che questo fine sarà raggiunto. Le due difficoltà erano queste; ora consideri come sono risolte dal metodo anarchico che il mio ragionamento mi ha portato a scoprire come l’unico valido. Tale metodo dà come risultato che io mi arricchisca; dunque: ricompensa egoistica. Il metodo cerca il conseguimento della libertà; ora, io, rendendomi superiore alla forza del denaro, cioè liberandomene, riesco a conquistare la libertà.
Ottengo libertà solo per me, certo; ma il fatto è che, come già le ho provato, la libertà per tutti può venire solo dalla distruzione delle finzioni sociali da parte della rivoluzione sociale, e io, da solo, non posso fare la rivoluzione sociale. Il fatto concreto è questo: cerco libertà, ottengo libertà; ottengo la libertà che posso, perché, è chiaro, non posso ottenere quella che non posso. E badi: metta da parte il ragionamento che determina che questo metodo anarchico è l’unico vero; il fatto che esso risolva automaticamente le difficoltà logiche che si possono opporre a qualsiasi procedimento anarchico, prova ancora di più che è quello vero.
È questo, dunque, il metodo che ho seguito. Ho dedicato tutte le mie energie all’impresa di
soggiogare la finzione denaro, arricchendomi. Ci sono riuscito. Ha richiesto un po’ di tempo, perché la lotta è stata dura, ma ci sono riuscito. Evito di raccontarle la mia vita commerciale e bancaria. Potrebbe essere interessante, soprattutto in certi punti, ma non c’entra più con l’argomento. Ho lavorato, ho lottato, ho guadagnato soldi; ho lavorato di più, ho lottato di più, ho guadagnato più soldi; alla fine ho accumulato molto denaro. Non mi son fatto scrupoli — glielo confesso, amico mio, non mi son fatto scrupoli; ho impiegato tutti i mezzi possibili: il monopolio, il cavillo giuridico, anche la concorrenza sleale. E come?! Combattevo le finzioni sociali, immorali e antinaturali per eccellenza, e dovevo stare attento ai metodi?! Lavoravo per la libertà, e dovevo stare attento alle armi con cui combattevo la tirannia?! L’anarchico stupido, che tira bombe e spara, lo sa bene che ammazza, e sa bene che le sue dottrine non contemplano la pena di morte. Si batte contro l’immoralità con un delitto, perché trova che questa immoralità valga bene il crimine che la distrugge. È stupido, lui, relativamente al metodo; perché, come già le ho dimostrato, questo modo di agire è sbagliato e controproducente quale procedimento anarchico; ma, quanto alla morale del procedimento, è intelligente. Ora, il mio modo d’agire era sicuro, e mi sono servito legittimamente, come anarchico, di tutti i mezzi per arricchirmi.
Oggi ho realizzato il mio sogno relativo di anarchico pratico e lucido. Sono libero. Faccio quel che voglio, nei limiti, è chiaro, di quanto è possibile fare. La mia parola d’ordine di anarchico era “libertà”; bene, ho la libertà, dunque; quella che, per il momento, nella nostra società imperfetta, è possibile avere. Volevo combattere le forze sociali; le ho combattute e, quel che più conta, le ho vinte».
«Un attimo! Un attimo! — dissi io — Tutto questo va bene, ma c’è una cosa che lei non ha
visto. Le condizioni del suo modo d’agire erano, come ha dimostrato, non solo creare libertà, ma anche non creare tirannia. Ora, lei ha creato tirannia. Lei come monopolista, come banchiere, come finanziere senza scrupoli — mi scusi, ma l’ha detto lei —, ha creato tirannia. Lei ha creato tirannia quanto qualsiasi altro rappresentante delle finzioni sociali, che lei sostiene di combattere».
«No, vecchio mio. Lei si sbaglia. Non ho creato nessuna tirannia. La tirannia che può essere
derivata dalla mia azione di lotta contro le finzioni sociali è una tirannia che non parte da me, e che quindi non ho creato io; è insita nelle finzioni sociali; non l’ho aggiunta io ad esse. Questa tirannia è la tirannia propria delle finzioni sociali, e io non potevo, né me lo sono mai proposto, distruggere le finzioni sociali. Per la centesima volta glielo ripeto: solo la rivoluzione sociale può distruggere le finzioni sociali; prima di questo, l’azione anarchica perfetta, come la mia, può solo soggiogare le finzioni sociali, soggiogarle in relazione al singolo anarchico che mette in atto questo processo, perché tale metodo non consente un maggiore assoggettamento di queste finzioni. Non si tratta di non creare tirannia: ma di non creare tirannia nuova, tirannia là dove non c’era. Gli anarchici, lavorando insieme, influenzandosi gli uni con gli altri come le ho detto, creano fra di loro, al di fuori delle finzioni sociali, una tirannia; questa è una nuova tirannia, ma non l’ho creata io. Non avrei potuto proprio, per le condizioni stesse del mio metodo. No, amico mio; io ho creato solo libertà. Ho liberato una persona.
Ho liberato me. Il mio metodo, che è, come le ho provato, l’unico veramente anarchico, non mi ha permesso di liberarne di più. Quelli che ho potuto liberare, li ho liberati».
«Va bene, sono d’accordo. Ma guardi che, con un discorso come questo, si è quasi portati a
credere che nessun rappresentante delle finzioni sociali eserciti tirannia».
«E non l’esercita. La tirannia è delle finzioni e non degli uomini che le incarnano; questi, per
così dire, sono i mezzi di cui le finzioni si servono per tiranneggiare, come il coltello è il mezzo di cui si può servire l’assassino. E lei, certo, non pensa che abolendo i coltelli si possano abolire gli assassini. Guardi: distrugga tutti i capitalisti del mondo, ma senza distruggere il capitale. Il giorno dopo il capitale, già nelle mani di altre persone, continuerà tramite loro la sua tirannia. Distrugga non i capitalisti ma il capitale; quanti capitalisti restano? Vede?»
«Sì, ha ragione».
«Ragazzo mio, il massimo, ma proprio il massimo di cui lei mi può accusare è di avere
aumentato un poco — molto, molto poco — la tirannia delle finzioni sociali. Il discorso è assurdo perché, come le ho già detto, la tirannia che io non dovevo creare, e non ho creato, è un’altra. Ma c’è ancora un punto che fa acqua: secondo lo stesso ragionamento, lei può accusare un generale, che combatte per il suo paese, di causare ad esso il danno del numero di uomini del suo stesso esercito che deve sacrificare per vincere. Chi va in guerra ne dà e ne prende. Si raggiunga l’obiettivo principale, ché il resto…»
«Benissimo. Ma consideri un’altra cosa. Il vero anarchico vuole la libertà non solo per sé, ma
anche per gli altri. Mi pare che voglia la libertà per l’umanità intera».
«Indubbiamente. Ma le ho già detto che, secondo il metodo che ho scoperto essere l’unico
modo d’agire anarchico, ognuno deve liberarsi da sé. Io mi sono liberato; ho fatto il mio dovere
contemporaneamente nei miei confronti e nei confronti della libertà. Perché gli altri, i miei compagni, non hanno fatto lo stesso? Io non gliel’ho impedito. Questo sarebbe stato il crimine: se li avessi ostacolati. Ma non li ho nemmeno ostacolati nascondendo loro il vero modo d’agire anarchico; non appena l’ho scoperto, l’ho esposto chiaramente a tutti. Questo stesso modo di agire mi impediva di fare di più. Che potevo fare? Forzarli a seguire la mia via? Anche se avessi potuto non l’avrei fatto, perché avrebbe significato togliere loro la libertà, e questo andava contro i miei principi anarchici. Aiutarli?
Anche questa soluzione era improponibile, per la stessa ragione. Non ho mai aiutato né aiuto nessuno, perché questo, che vuol dire diminuire la libertà altrui, va anche contro i miei principi. Lei mi sta rimproverando il fatto che io non sono altro che una persona sola. Perché mi rimprovera l’adempimento, nei limiti del possibile, del mio dovere di libertà? Perché non rimprovera prima loro, per non aver compiuto il loro dovere?»
«Certo. Ma quegli uomini non hanno fatto quello che ha fatto lei naturalmente, perché erano
meno intelligenti di lei, o dotati di minore forza di volontà, o…»
«Ah, amico mio: queste sono le disuguaglianze naturali, non quelle sociali. Con queste,
l’anarchia non ha niente a che vedere. Il grado di intelligenza o di volontà di un individuo riguardano lui e la natura; le finzioni sociali non c’entrano per niente. Alcune qualità naturali, presumibilmente, sono state pervertite dalla lunga permanenza dell’umanità fra le finzioni sociali, come già le ho detto; ma la perversione non sta nel grado della qualità, che è dato in modo assoluto e definitivo dalla natura, bensì nella sua applicazione. Ora, una questione di stupidità o di mancanza di volontà non ha niente a che vedere con l’applicazione di tali qualità, ma solo con il loro grado. Perciò le dico: queste, ormai, sono differenze naturali e definitive, sulle quali nessuno ha alcun potere; né esistono rivolgimenti sociali che le modifichino, così come non si può far diventare me alto o lei basso.
A meno che… a meno che, in un caso di questo tipo, la perversione ereditaria delle qualità
naturali non si spinga così avanti da attingere al fondo stesso del temperamento… Sì, che un individuo nasca per essere schiavo, naturalmente schiavo, e quindi incapace di qualsiasi sforzo per liberarsi. Ma in questo caso… in questo caso, cosa ha a che vedere un simile individuo con la società libera, o con la libertà? Se un uomo è nato per essere schiavo, la libertà, essendo contraria alla sua indole, sarà per lui una tirannia».
Una breve pausa. Improvvisamente cominciai a ridere forte.
«È vero — dissi — lei è anarchico. In ogni caso, fa venir da ridere, anche dopo averla ascoltata,
paragonare lei con gli anarchici che sono in giro…»
«Amico mio, gliel’ho detto, gliel’ho provato e ora glielo ripeto. La differenza è tutta qui: loro
sono anarchici solo teorici, io sono teorico e pratico; loro sono anarchici mistici e io scientifico; loro sono anarchici che si piegano, io sono un anarchico che combatte e si libera… In una parola: loro sono pseudoanarchici; io, invece, sono anarchico».
E ci alzammo da tavola.
Lisbona, gennaio 1922

La struttura del racconto é imperniata sul colloquio tra due interlocutori in cui il secondo tende a scomparire dalla trama se non per pochi interventi da “spalla”,senza contraddittorio apparente;infatti pare una sceneggiatura perfetta per una pièce teatrale o per una performance di un attore che non teme il confronto con il pubblico.
Appare chiaro in prima istanza che é un racconto che potrebbe essere scritto da un filosofo della scuola dei Sofisti, la cui logica apparente é quella di dimostrare che si può partire difendendo una posizione e tramite una logica stringente arrivare alla fine difendendo le posizioni opposte.
La Sofistica é un movimento culturale e filosofico sorto in Grecia nei secc. V-IV a.C., che, rifiutando ogni ricerca metafisica, instaurò il principio della soggettività del sapere identificando nella convenienza pratica l’unico criterio della verità di
un’affermazione, e a tale scopo valorizzando al massimo la retorica, considerata l’unico efficace mezzo di convinzione e persuasione.
Attraverso sillogismi e paralogismi che investono il lettore attraverso labirinti logici spietati,in cui ogni passaggio é validato da quello precedente, l’idea del libertarismo anarchico viene completamente svuotata del suo significato per approdare in un esasperato individualismo egoista che rivendica la bontà della scelta fatta come unica risultante possibile.
A ben guardare il ragionamento si regge su una catena di presupposti, ciascuno dei quali è appena più estraneo alla verità rispetto a quello che lo precede, definendo una linea logica all’apparenza diritta,ma in realtà che si muove zigzagando. Anche un concetto
fondante del discorso come “la realtà naturale”,a cui il banchiere si appella in continuazione per corroborare il suo ragionare, appare non compiutamente focalizzato,rimanendo fuori dal cono di luce logico,opaco, quasi come un apriori kantiano.
Ritengo che,visto da questa prospettiva,il discorso sull’anarchia rappresenti per l’autore solo una scusa,un alibi, per mettere in guardia il lettore dall’imprudenza nel percorrere sentieri che attraverso l’uso spregiudicato della retorica e della logica approdino in uno
sterile solipsismo egoista, amorale , vanesio e privo di autentica libertà .
Questa chiave interpretativa é anche aiutata dalla biografia e dagli interessi culturali preponderanti in Pessoa, dedito quasi ossessivamente non ad elucubrazioni in chiave politico-sociale, ma scaturenti dal corpus della filosofia irrazionale,dall’occultismo, dal misticismo,dall’ ermetismo e dall’ astrologia di cui era profondo cultore. Era nota anche la sua vicinanza all’antroposofia steineriana, alla kabbala ebraica e i suoi contatti con la massoneria di origine anglosassone. Assolutamente lontano quindi da ogni tipo di elaborazione politica, se non come riferimento ad una tiepida partecipazione al conservatorismo antireazionario con simpatie monarchiche. Se vogliamo trovare interlocutori a lui affini possiamo cercare nella galassia degli eruditi mistici di stampo est-europeo come Mircea Eliade oppure il nostro Elemire Zolla. Il suo é stato un costante dialogo e interrogazione con la sua coscienza/e, soliloquio interiore che lo avvicina moltissimo all’esperimento letterario dell’Ulisse di James Joyce.
Possiamo dunque asserire,in buona sostanza, che il Banchiere anarchico serve al nostro per demolire il logos greco, la spietatezza della logica su cui si fonda un’umanità rapace e solitaria,perfetta descrizione delle pulsioni dell’uomo occidentale contemporaneo.
Ma, se il libro di Pessoa rimanda ad altro, io ne accetto la “provocazione” linguistica e retorica, atteggiamento utile per rintuzzare gli attacchi che da sempre vengono portati all’anarchismo libertario in base allo stilema di irrealizzabilità ed utopia che ne contraddistinguerebbe l’esito.
Il logos del Banchiere anarchico si muove tra i poli delle “finzioni sociali”, forze oscure che minacciano l’uguaglianza e la libertà dell’uomo, e la “realtà naturale” costituita dai caratteri intimi e personali posseduti da ciascuna persona, che ne fanno ciò che si é in termini di unicità ed originalità.
Senza rincorrere l’intero itinerario biografico del Banchiere anarchico e le trappole semantiche ivi annidate, così ben caratterizzate dalla scrittura del portoghese, vorrei soffermarmi su due aspetti del discorso che, appena focalizzati con maggior rigore, permettono di comprendere come la retorica e la logica, evidenziando certi aspetti ed occultandone altrettanti, piegano il senso del discorso verso una fine ineluttabile ancorché privo di contraddizioni.
Il punto nodale, a mio parere,rimane la non veridicità dell’asserzione secondo cui anche nei gruppi anarchici si ha la produzione di una nuova tirannia, contraddicente quelle che sono le istanze del credo libertario:“Nel gruppo di propaganda —non eravamo molti, una quarantina di persone, se non sbaglio — accadeva questo: si produceva tirannia[…..]: qualcuno comandava sugli altri e ci portava dove voleva; qualcun altro si imponeva e ci obbligava a essere quello
che più piaceva a lui; altri ancora trascinavano i compagni dove volevano, con imbrogli e artifici vari. […]. Qualcuno andava impercettibilmente verso le posizioni di comando, altri impercettibilmente verso il ruolo di subordinati. “
Il banchiere,ad uso della sua tesi, confonde la nuova tirannia nei gruppi anarchici con il concetto di Potere,quello sì combattuto sempre e comunque da
qualsiasi anarchico che si rispetti. Egli confonde potere con carisma e competenza personale,messe al servizio della causa comune. Sia Illich che Bookchin
parlano di questi aspetti tratteggiando le prerogative delle piccole comunità anarchiche fulcro dell’organizzazione sociale libertaria. La prospettiva così designata ,cioè mettere le proprie competenze personali al servizio del gruppo, delinea il secondo aspetto che dolosamente (o incolpevolmente?) il banchiere di Pessoa evita di mettere in luce: nella cosidetta “realtà naturale” vengono considerati solo gli aspetti privati dell’individuo come la forza, l’intelletto,la volontà,la scaltrezza,l’intelligenza , i parametri fisici che sono naturalmente diversi per ciascun uomo. Ma l’uomo,in primis, é soggetto sociale, comunitario,come e in maggior misura di tante altre specie che popolano la terra. Molte discipline lo hanno evidenziato,antropologia,sociologia, zoologia, linguistica, neurofisiologia (a cosa servirebbero altrimenti i neuroni specchio?),teoria della mente e della coscienza (Bateson,Maturana),
neuropsicologia(Varela). In psicologia dell’età evolutiva viene sempre rimarcato il lungo periodo di svezzamento di cui abbisogna il cucciolo umano,rispetto alle altre specie,per il farsi di una coscienza marcatamente simbolica (Vygotsky,Piaget).Non si può mai disgiungere l’uomo dall’ambiente in cui cresce e vive, così come non é più tempo di spezzare la sua originaria unità nel pernicioso dualismo mente-corpo, come dimostrato dalle ricerche riguardo la cognizione
incarnata in psicologia cognitiva. Privandosi della sua parte sociale, a vantaggio di una fittizia volontà di potenza basata su un’utopica “realtà naturale” , il banchiere pessoiano approda in un territorio mai esplorato in Natura, che sempre media i rapporti intra ed extra specie con quello che definiamo istinto, un territorio dicevo che appare di sconfinata libertà, ma in buona sostanza che lo colloca in una unidimensionalità marcusiana estraniante e distopica.
Sotto questo aspetto il banchiere anarchico,lungo l’arco del racconto, si industria alacremente nello spogliarsi delle sue sembianze più genuinamente umane, isolandosi vieppiù dagli antichi compagni, per approdare nella macchina acchiappa denaro che diventa alla fine del racconto,
il mezzo che diventa il fine, l’accumulo opposto al donarsi incondizionato agli altri. Nell’anarchia libertaria si sceglie di camminare insieme, si andrà più lenti, ma alla fine si farà più strada e soprattutto sarà anche più gratificante.
Rimane da chiedersi la causa che porta tante persone, anche lucidissime, fittizie come in questo racconto ma anche reali,( chi non li ha mai incontrati nella realtà ?) ad avere il disperato bisogno di dimostrare,prima di tutto a loro stessi, la bontà e la moralità delle loro azioni anche se la realtà dice altro.
“ E chi desidera essere malvagio, vale a dire un uomo che agisce come se tutte le azioni fossero difendibili, dovrebbe almeno avere la bontà di accorgersi quando è riuscito nel suo scopo.“(Stig Dagerman -Il nostro bisogno di consolazione)
Rimane solo l’ironia a spiegare quello che non si può.
In quanto a Fernando Pessoa appartiene alla genia degli uomini con orizzonti diversi da quello terrestre, come Poe, Baudelaire o Arthur Rimbaud , abitatori delle linee d’ombra, dei dormiveglia, dell’incessante formula dell’infinito, dell’ Io é l’altro.
Ma appartiene anche al mondo dei bambini, quando soli,chiusi nella stanzetta di casa, si inventa un amico immaginario con cui giocare,in cui specchiarsi, una fiammella rischiarante un mondo incompreso, un eteronimo in fieri che ti accompagna nel cammino che cammino non é.
Uomo multiforme Pessoa,uno nessuno centomila, l’esatto contrario dell’uomo unidimensionale senza ombra,il banchiere anarchico.
Ha trovato in vita la quintessenza del mistero di cui siamo portatori ,enigma fatto persona, formula magica che l’ha accompagnato dalla nascita alla morte:
«Se dopo la mia morte volessero scrivere la mia biografia,non c’è niente di più semplice.
Ci sono solo due date – quella della mia nascita e quella della mia morte.
Tutti i giorni fra l’una e l’altra sono miei.»